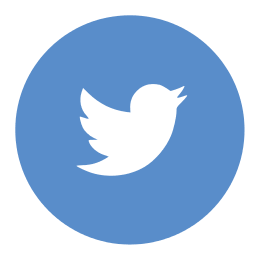Una taberna a Ostia Antica, Roma; l’affresco sopra il bancone mostra ciò che veniva offerto nell’osteria: cibo, bevande e musica.
| TABERNA |
Nell’antica Roma la taberna (al plurale tabernae) era una sorta di ristorante o trattoria, tipicamente dotata di una sola stanza con volta a botte. La taberna nacque inizialmente come deposito ed era, in genere, la bottega degli artigiani, aperta verso la strada; si passò poi alle tabernae vinarie e a quelle che si specializzarono nella consumazione del vino e del pasto.
Le tabernae avevano un bancone di pietra, con cinque o sei contenitori murati, rivolti verso la strada; accanto al banco vi era un fornello con una casseruola piena di acqua calda; nel retro c’erano la cucina e le sale per la consumazione. Avevano una finestra in alto che dava luce al soffitto in legno del deposito ed un grande vano di apertura sulla strada.
Un famoso esempio si trova nei mercati di Traiano, costruiti da Apollodoro di Damasco. Secondo la “Cambridge Ancient History”, la taberna era un’unità per la vendita al dettaglio all’interno dell’ Impero Romano, in più era il luogo dove venivano offerte numerose attività commerciali e terziarie, comprese la vendita di cibi cotti, vino e pane.
Tito Livio descrive l’aspetto delle tabernae (botteghe) nelle strade di Tusculum, in riferimento ad una visita di Marco Furio Camillo:
.
«Camillus castris ante portas positis, eademne forma pacis quae in agris ostentaretur etiam intra moenia esset scire cupiens, ingressus urbem ubi patentes ianuas et tabernis apertis proposita omnia in medio uidit intentosque opifices suo quemque operi et ludos litterarum strepere discentium uocibus ac repletas semitas inter uolgus aliud puerorum et mulierum huc atque illuc euntium qua quemque suorum usuum causae ferrent, nihil usquam non pauidis modo sed ne mirantibus quidem simile, circumspiciebat omnia, inquirens oculis ubinam bellum fuisset; adeo nec amotae rei usquam nec oblatae ad tempus uestigium ullum erat sed ita omnia constanti tranquilla pace ut eo uix fama belli perlata uideri posset.»
.
« …Posto il campo di fronte alle porte, Camillo, desiderando sapere se anche all’interno delle mura appariva la stessa aria di pace che si ostentava nelle campagne, entr? in citt?. L? vide le porte delle case spalancate, le botteghe aperte, con tutta la mercanzia bene in vista, gli artigiani impegnati ciascuno nel proprio lavoro, le scuole che risuonavano per le voci degli scolari, le strade piene di gente con donne e bambini mescolati tra la folla e diretti l? dove i rispettivi impegni li chiamavano, il tutto senza avvertire da nessuna parte non solo alcun segno di paura ma nemmeno di stupore. Camillo si guardava intorno con attenzione, cercando di scoprire le tracce tangibili di una guerra imminente. Ma non c’era alcun segno di cose spostate o preparate per l’occasione. Anzi tutto era cos? immerso in una quiete pacifica e costante, che sembrava impossibile vi fosse anche solo arrivata una qualche notizia della guerra..….»
.
(Tito Livio, Ab Urbe condita libri, VI, 25)
| TAVERNA |
La taverna nel Medioevo era un luogo di ritrovo per bere, mangiare, incontrarsi, giocare.
La documentazione principale sulla presenza della Taverna nella vita sociale del Tardo Medioevo ci è fornita dagli Statuti delle città.
Le Taverne erano ubicate sia nei centri urbani che nei piccoli borghi nelle campagne, ma soprattutto nei luoghi di mercato, lungo i fiumi in prossimità di ponti e traghetti e le strade, nei porti; tutti posti nei quali vi era molta gente di passaggio o stanziale. Erano sorvegliate dalle autorità.
La Taverna medievale era caratterizzata da un’insegna e da dei lunghi sporgenti pali per la birra che però spesso recavano fastidio alla circolazione, e a Londra nel 1375 vi fu un provvedimento che ne limitava a 7 piedi la misura massima di sporgenza dalla facciata. Lo statuto della città di Verona del 1327 ci trasmette la possibile esistenza di un cortivum o di un porticus: ne è facile dedurre che durante la buona stagione i Vini, la Birra, i Distillati, l’Ippocrasso e l’Idromele venivano consumati all’esterno in quello che è altrove definito “circuito della taverna”.
Fonte: lamescaligere.it
| Ricette |
- “Scapece da taberna”
- Alici in scapece
- Zucchine a scapece
- I. ABEMUS IN CENA, menù dell’antica Roma
- II. ABEMUS IN CENA, menù dell’antica Roma
- III. ABEMUS IN CENA, menù dell’antica Roma
Bevande
.
.
.
.
- Vino Mulsum (antica Roma)
- Vino Conditum Paradoxum (antica Roma)
- Ippocrasso, il vino speziato del Medioevo
- Idromele, bevanda medievale per la “Luna di miele”
| Carmina Burana In taberna quando sumus |
sono testi poetici contenuti in un importante manoscritto del XIII secolo, il Codex Latinus Monacensis o Codex Buranus, proveniente dal convento di Benediktbeuern (l’antica Bura Sancti Benedicti fondata attorno al 740 da San Bonifacio nei pressi di Bad Tölz in Baviera) e attualmente custodito nella Biblioteca Nazionale di Monaco di Baviera.
-
Struttura e contenuti.
-
La musica nei Carmina Burana
-
L’opera teatrale di Carl Orff
-
Discografia (interpretazioni della versione originale)
-
Bibliografia
Se vuoi ascoltare:
-
In taberna quando sumus – Carl Orff, Carmina Burana con testo in Italiano, latino e inglese
-
Carl Orff – Carmina Burana 1:03:44 (video)
Carmina Burana: “In taberna quando sumus” 196Testo ©2001 Saltatio Mortis |
Traduzione ©2008 Daniele Benedetti |
In tabernaIn taberna quando sumus
|
All’osteriaQuando siamo all’osteria
|